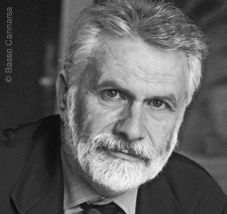Raffaele Nigro è scrittore e giornalista nato a Melfi (PZ) e residente in Puglia. E’ stato caporedattore per la sede regionale RAI e ha intrapreso l’attività di scrittore negli anni Settanta, conducendo approfondite ricerche sulla storia della Basilicata e dell’Italia Meridionale. E’ fine conoscitore d’arte e intellettuale militante nella scena culturale meridionale e nazionale. Ha ricevuto numerosi e prestigiosi premi, tra cui il Super Campiello, nel 1987, con il romanzo “I fuochi del Basento“. “Il custode del museo delle cere” è il romanzo di più recente pubblicazione (2013). Qui maggiori informazioni sulle sue attività e pubblicazioni.
Il suono delle parole: una riflessione sul passaggio dal racconto orale alla stampa. Cosa è cambiato, oltre al silenzio della carta stampata?
Quando eravamo ragazzi eravamo molto abituati ad ascoltare la voce dei nonni, dei cantastorie, ma soprattutto si ascoltavano i canti per strada. C’era una oralità diffusa, tanto che il tasso di analfabetismo si aggirava intorno all’85% ed era dovuto anche al fatto che la trasmissione della cultura era tutta affidata all’oralità. Chi raccontava, però, aveva il senso delle pause e la pausa era il silenzio. Quindi il silenzio serviva per dare significato e profondità alle parole e ai racconti che poi sarebbero seguiti. Ovviamente il passaggio da una comunicazione orale ad una comunicazione scritta, fatta per segni convenzionali, ha portato ad un silenzio totale perché il rapporto è stato sempre più tra il lettore e la pagina scritta.
Oppure è stato un ascolto di quello che veniva dai mezzi di comunicazione di massa, che potrebbe sembrare un ritorno all’oralità ma in realtà non lo è perché c’è un orante, uno che parla, e chi è costretto ad ascoltare continuamente senza poter interagire.
Gli audiolibri, dove un testo scritto viene letto da un attore o dall’autore stesso, hanno qualche attinenza con il racconto orale?
No, perché manca l’interazione tra chi ascolta e chi legge. C’è una questione molto importante nella lettura diretta e viva di chi parla e interloquisce ed è data dalla gestualità, dagli occhi che guardano negli occhi di chi ascolta e, quindi, dall’azione che si stabilisce tra gli sguardi che si cercano e che si incontrano. Questa interazione è fondata su attimi di silenzio, quello dello sguardo che è importantissimo.
Le parole sono importanti, perché devono spiegare: per esempio, quando abbiamo iniziato a lavorare alla RAI, gli operatori di ripresa suggerivano che si potessero realizzare i servizi anche senza parlare. Non era così, perché le parole spiegano, le immagini descrivono e raccontano ma non scendono in profondo nei fatti e nei sentimenti. Prendiamo due innamorati: si parlano e si guardano, oppure non parlano; in effetti due persone cosa si dicono in quel momento?! Eppure c’è un io profondo che sale fino agli occhi e, attraverso lo sguardo, ossia attraverso quel segmento che si stabilisce tra l’osservatore e l’osservato, emerge un dialogo che è anche più profondo del parlato stesso. In fondo, le parole per dirsi l’amore quali sono? Ti amo, ti voglio bene, ti adoro, sei tutta la mia vita, sei l’anima mia: poi finiscono e il silenzio degli occhi è molto più ricco e più profondo.
John Cage, in “Conferenza su niente”, recita: “ma adesso ci sono silenzi e le parole fanno, aiutano a fare silenzi”. Il silenzio, inteso come pausa che tende verso il suono, viene annullato nella lettura di parole scritte? La punteggiatura è capace di valorizzare la funzione drammatica del silenzio?
La punteggiatura è importante e, a seconda del suo uso, possiamo conferire rapidità o meno al discorso. Per esempio, quando io scrissi “I fuochi del Basento”, siccome volevo dare concitazione al racconto, mi inventai la serialità dei sostantivi e degli aggettivi. Era una struttura che avevo copiato dalla proposizione ciceroniana e che si era imbattuta, scontrandosi, con la frase petrarchesca. Però Petrarca si era adeguato e aveva scritto “chiare, fresche e dolci acque”…oppure “e valli e monti e clivi” perché lui, essendo triste e lento, dava cadenza al suo passo.
Nel mio caso, invece, io avevo bisogno di costruire un racconto epico e, optando per la serialità dei sostantivi e degli aggettivi, la punteggiatura mi dava fastidio perché le virgole, i punti, i punti e virgola interrompevano l’accelerazione del mio racconto. Quindi l’utilizzo della punteggiatura è importante proprio in funzione del modo in cui vuoi esprimere ciò che hai dentro e i tuoi sentimenti, cioè il modo, la velocità e il tempo nel quale vuoi bruciare ciò che racconti.
Che funzione hanno le figure retoriche, soprattutto quelle sonore (allitterazione, assonanza, ripetizione, etc.), nella costruzione di un discorso sia orale, sia scritto?
In poesia le figure retoriche sono state importanti per creare componimenti assonanzati o basati sulla rima, avendo la funzione di accrescere la musicalità del verso. Poi si è scoperto il verso libero e quella musicalità, più tradizionale, è venuta meno. Tuttavia, come dicevo prima, quando si vuole costruire un processo epico, un passo di fanfara, un movimento molto veloce e ritmato allora si ricorre a tutte le figure retoriche possibili e immaginabili. La poesia sonora ne è un esempio, in cui si utilizzano prevalentemente le onomatopee. Pensiamo alla “poesia della tosse”. C’è una registrazione di una “poesia della tosse” nel cinema: qualcuno comincia a tossire, un altro risponde e poi le voci si incrociano e viene fuori, alla fine, un grande concerto.
Dal paroliberismo futurista all’invenzione di un vocabolario da parte di alcuni scrittori (“Finnegans Wake” di James Joyce o “Riddley Walker” di Russel Hoban): qual è la sua funzione?
Si tratta del bisogno di inventare un linguaggio: oggi è diventato per il poeta, per il narratore sperimentale una reazione alla sclerotizzazione del linguaggio prodotta dal giornalismo. Il giornalismo tende a ridurre il numero di vocaboli, perché chi legge deve rifarsi ad un vocabolario ristretto e povero ma che è tale, però, che si possa dialogare con poco e in poco tempo. Compito del narratore e del poeta, invece, è quello di allargare l’area del linguaggio che è come voler far esplodere continuamente delle bombe, un big bang continuo. Qui risiede la necessità dell’invenzione linguistica che serve anche per rendere angoli e segmenti del sentimento che non sono stati espressi o che è difficile esprimere.
Anche l’attuale società, che si trasforma continuamente con nuove parole, vocaboli e sostantivi legati ad apparecchiature e a tecnologie moderne, richiede la necessità di re-inventare il linguaggio.
“Io sono apparso quella notte alle Madonne che ululavano per lo stupore e il terrore, Madonne che si liberavano dei loro chador neri e trapuntati. […] Tutte uscirono in strada, e si liberarono del manto e si sciolsero i capelli, gridando come prefiche e decise a ribellarsi al loro ruolo di addolorate, di consolatrici, di desolate, di riparatrici. Io avevo accolto l’invito del re del fuoco, avevo accettato la ribellione ed ero apparso in cielo per raccontare la verità agli altri e sfuggire alla costrizione io stesso” (pp 122-123).
Cito un passo del tuo romanzo di recente pubblicazione, “Il custode del museo delle cere”, per chiederti di riflettere sulla ricerca sonora da parte di Carmelo Bene.
Credo che lui sia partito da Demetrio Stratos: credo che Carmelo Bene sia partito da questi gruppi, non solo greci ma anche americani, che hanno giocato, appunto, sulla gutturalità, sullo strascico della voce. Tant’è che Bene ha provato a far sparire persino la parola, ad esempio nella lettura dell’ “Inferno” e del “Purgatorio” di Dante, e ha provato a far combaciare il solo suono, la sola espressione gutturale con un sentimento o con le anime che salivano dall’inferno, creature che erano e non erano vive; a quel punto, quindi, il sonoro diventava esistenza stessa o diventava silenzio totale quando voleva raffigurare la morte o l’inesistenza delle cose.
Un racconto di suoni della tua memoria.
Ho in mente suoni di varia natura. Per esempio, ricordo quando mia madre mi faceva il malocchio: mi cominciava a fare le croci sulla testa, sulla nuca e recitava delle formule magiche che però erano appena dette, io sentivo e non sentivo le sue parole, capivo e non capivo il significato delle parole. Erano di questo tipo: tre occhi ti hanno adocchiato, tre santi ti devono aiutare e non ti aiutano come figlio mio ma ti aiutano come figlio di Maria… Questo, ripetuto e ripetuto, finiva col diventare una canzone, una melopea e questo suono lo ricordo come un fatto ancestrale, come un fatto molto intimo. Poi c’era la voce della natura. Ricordo, per esempio, quando andavo con papà sul Vulture e c’era il torrente dell’acqua minerale che scrosciava e si poteva sentire il continuo salto dell’acqua. In questo salto d’acqua si inserivano qualche canto di gazza, qualche canto di fringuello ed era tutta un’armonia di voci e di suoni che erano un linguaggio: un linguaggio fatto di non-parole, che erano le parole di quel mondo.